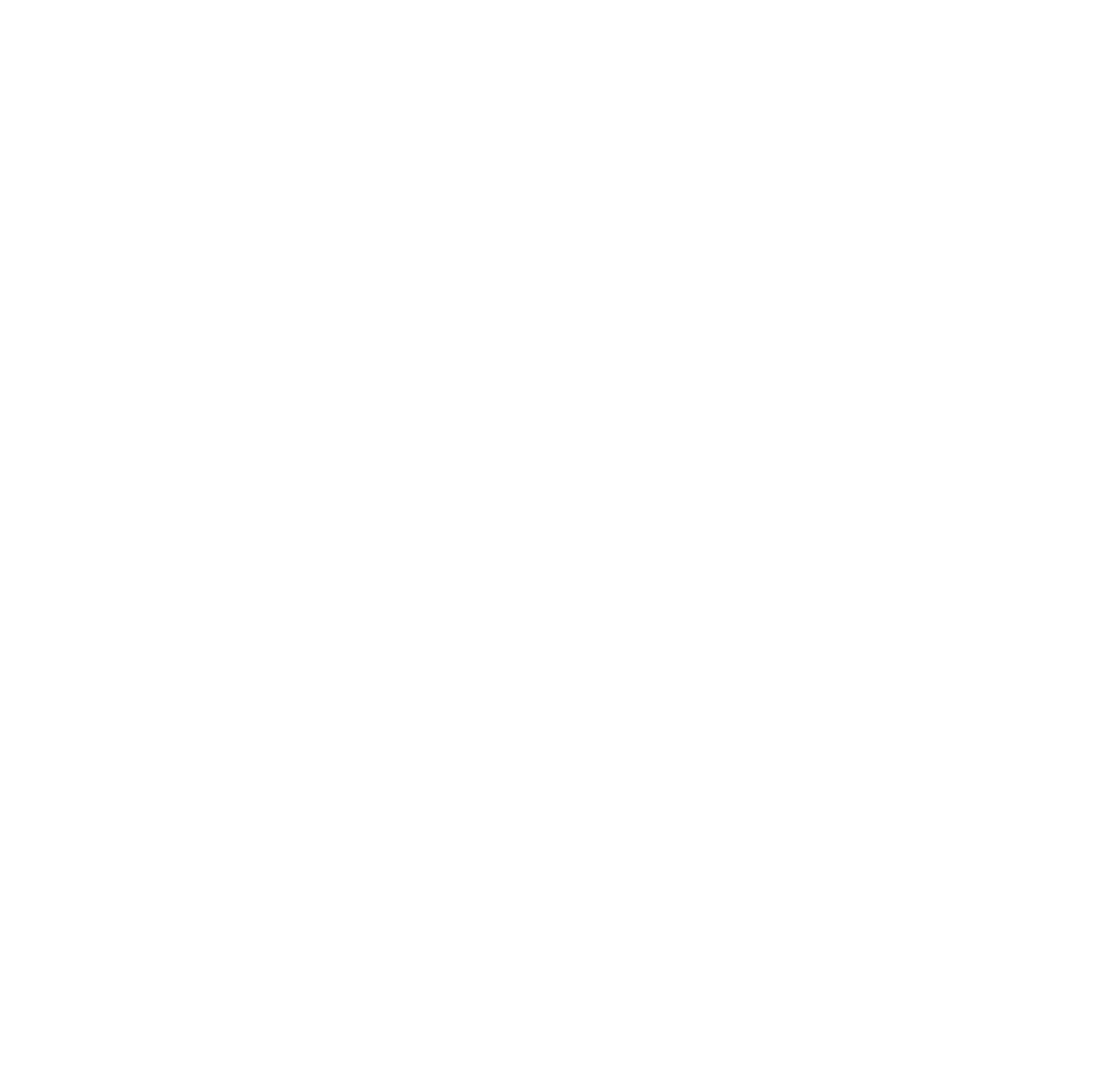Non un momento, ma un processo: l'attesa.
Vivere, non attendere
Se dovessimo definire l'attesa, potremmo dire che è principalmente una percezione della nostra mente. Pur sapendo che lo scorrere del tempo è relativo, e che la sua velocità è influenzata da come lo percepiamo, l'attesa si manifesta nel momento in cui ci aspettiamo che qualcosa o qualcuno arrivi, o non arrivi.
L'attesa, quindi, è una dimensione che ci sottrae al presente, impedendoci di viverlo appieno. Ci proietta in una dimensione temporale in cui il tempo sembra scorrere molto lentamente, quasi ingabbiandoci in una prigione che ci impedisce di cogliere le diverse opportunità che la vita ci offre.

A volte è attesa, a volte è aspettativa
Quindi sostanzialmente l'attesa non è altro che una proiezione della nostra mente, rispetto alla dimensione temporale che stiamo vivendo. Questo aspetto è strettamente correlato a un altro, ovvero l'aspettativa. C'è una vera è propria stretta relazione tra l'aspettativa e l'attesa, perché essa l'alimenta a tutti gli effetti. In che modo? Beh quando pensiamo a qualcosa o a qualcuno che vorremmo arrivasse, viviamo di aspettative, ovvero in relazione a quella cosa o persona che desideriamo. Di conseguenza, finché questa cosa o persona non si manifesta nella realtà, viviamo nell'attesa.
Fin qui, tutto straordinariamente abituale, ma la verità è che non è proprio così. Per poter meglio comprendere il perché, è necessario conoscere qualcosa in più sull'aspettativa.
Essa è un'esperienza prettamente cognitiva e ha un processo complesso che porta a generarla, che comprende diverse fasi e meccanismi. Input e informazioni, sono elementi centrali di questo meccanismo, che si genera proprio attraverso esperienze passate, osservazioni e apprendimento sociale. Per quanto riguarda il primo aspetto, possiamo dire che l'esperienze giocano un ruolo fondamentale, in quanto dal momento in cui viviamo momenti simili a quelli passati, tendiamo a creare associazioni e quindi aspettative, relative all'evento che stiamo vivendo.
Nel secondo caso invece, le persone possono generare aspettative, attraverso l'osservazione degli altri (modello di apprendimento di Albert Bandura, noto come apprendimento osservazionale). Osservare come gli altri reagiscono ai loro eventi genera in noi aspettative su come reagiremmo noi stessi in situazioni simili.
Elaborazione cognitiva, è la seconda fase che caratterizza questo processo e si basa a sua volta su due elementi principalmente: lo sviluppo di credenze e le emozioni correlate. Le aspettative si intrecciano con le convinzioni personali. Le credenze su se stessi, sulle proprie capacità e sul mondo circostante influenzano profondamente le aspettative che nutriamo su di noi e sui nostri risultati. Dall'altra parte, l'emozioni svolgono un ruolo significativo nel modellare le nostre aspettative. Emozioni positive come entusiasmo e fiducia accompagnano aspettative positive, mentre aspettative negative possono generare ansia o, nei casi più gravi, depressione.
Un'altra fase importante del processo di formazione sistema, è la parte che riguarda il feedback e l'adattamento, che comprende la valutazione degli esiti e l'apprendimento dall'esperienza. Dopo aver vissuto una situazione in cui l'aspettativa si concretizza, tendiamo a reiterare gli stessi meccanismi che consideriamo efficaci.
Il feedback ottenuto dall'esperienza futura, invece, aiuta a modificare le aspettative; esiti negativi possono portare a possibili rivalutazioni, con una maggiore cautela in future situazioni simili.
Spesso, attesa e aspettativa vengono paragonate o utilizzate come sinonimi per esprimere la stessa condizione cognitiva: la proiezione di un possibile evento futuro. Mentre la prima riguarda un'interpretazione cognitiva del tempo, che interpone la persona tra il momento della non-azione e il desiderio che un evento si verifichi, la seconda è pur sempre una lettura cognitiva legata a una speranza, un desiderio, una credenza o un presunto merito di qualcosa che deve ancora (forse) accadere.
Oltre al tempo, troviamo diversi elementi comuni tra i due atteggiamenti. Le emozioni, ad esempio, vengono influenzate dalle aspettative e a loro volta hanno un'influenza specifica sull'attesa stessa; conseguenza è che se avrò delle aspettative positive, vivrò emozioni come la fiducia o l'entusiasmo, che miglioreranno il tempo dell'attesa. Un altro aspetto è il controllo. Di fatto esso potrebbe essere un tentativo della nostra mente, per esercitare il controllo su un evento futuro che in realtà sfugge al controllo stesso.
In conclusione, possiamo affermare che entrambi questi aspetti ci proiettano in un momento futuro non ancora verificato, facendoci vivere in uno stato di non-azione.
Non si tratta di attendere, ma di vivere
Tra le attese e le aspettative, probabilmente ti starai chiedendo in che modo sia possibile non viverle o evitarle, ma la risposta che si presenta è sempre la stessa: è impossibile. La verità è che non solo siamo abituati a praticarle, ma non è possibile vivere senza sentirne il peso, così come quello delle aspettative. Lo so, adesso starai pensando che quando si è in situazioni difficili, dove ci si sente impotenti, l'attesa come le aspettative diventano inevitabili.
Comunque entrambi sono aspetti cognitivi che quindi riguardano la nostra mente e il modo in cui elabora le situazioni; di conseguenza, se riuscissimo a intervenire su tale processo, potremmo imparare a vivere diversamente, imparando a gestire i due aspetti apparentemente inevitabili.
Come? È essenziale, prima di tutto, comprendere che entrambi questi meccanismi appartengono a una dimensione mentale e, come tale, non sono reali in senso assoluto, ma sono solo un modo in cui noi percepiamo la realtà. Una volta fatto ciò, bisogna orientarsi verso pratiche che ci permettono di vivere il momento presente, l'unica vera dimensione temporale. Il passato è un momento temporale che non esiste più e tutto ciò che gli appartiene non c'è, non ci appartiene in nessun modo. Il futuro è sicuramente un tempo che è destinato a verificarsi, ma fino a quel momento rimane un tempo sconosciuto e che non conosciamo minimamente.
Quindi non ci rimane che il presente, il momento che si identifica con il famoso "qui e ora". Dal momento che viviamo nel qui e ora, possiamo solo raccogliere le esperienze del passato e imparare da esse per non ripresentare gli stessi meccanismi limitanti nel futuro, ma vivendo comunque sempre il presente.
Vivere ogni giorno significa cogliere quello che la vita ci offre in ogni momento come opportunità di crescita e di miglioramento di se stessi, ricordando che l'opportunità non è data sempre dal momento favorevole (quando le cose vanno bene), piuttosto dai momenti difficili, dalle crisi o da quei momenti in cui le cose non vanno come vorremmo. È proprio in questi momenti che dovremmo imparare a cogliere le opportunità, nel presente, scegliendo strade diverse rispetto a quelle che magari stiamo percorrendo, oppure apportando modifiche a quelle già esistenti. La chiave non è attendere il momento opportuno perché le cose migliorino, né tanto meno aspettarsi qualcosa o qualcuno che arrivi perché le cose migliorino.
Focalizzarsi sul presente, viverlo, vuol dire impegnarsi su quello che abbiamo già, non su qualcosa o qualcuno che vorremmo arrivasse. Significa impegnarsi in maniera costante sugli aspetti quotidiani che ci appartengono e che non sono efficaci come crediamo, ma che soprattutto non ci permettono nemmeno che ciò che desideriamo e che stiamo così tanto attendendo arrivi.
Investire su se stessi, rivolgere i riflettori verso noi stessi senza lasciare che le energie vengano disperse, ma solo investite, è una pratica che ti permetterà di vivere appieno la vita, stando nel presente, minimizzando i momenti di attesa e riducendo le aspettative. Il trucco è molto semplice, ma bisogna avere il coraggio di volerlo davvero; ci vuole coraggio per scegliere di vivere una vita serena.

Chi ha stabilito le regole del "gioco"?
Perché continuiamo a vivere come se stessimo aspettando? L' opportunità migliore, il lavoro migliore, l'auto migliore, la casa più grande e più bella, la relazione perfetta, la donna o l'uomo perfetto e così via desiderando, ci perdiamo alcuni aspetti della vita.
Uno di questi è che essa non ci darà quasi mai ciò che desideriamo (solo perché non è realmente ciò che costruttivo), piuttosto ciò che ci torna utile per la nostra vita, per la nostra esistenza o per i futuri progetti che ancora non conosciamo. Tutto ciò che ci accade, anche le situazioni più difficili o alcune persone non adatte a noi, sono comunque parte di un processo, utile per evolverti e per renderti migliore, una versione sempre migliore di te stesso.
Dal momento invece in cui si ha un desiderio o comunque la volontà di ottenere un qualcosa, perché attendere o sperare che questa arrivi a noi in qualche modo? La verità è che siamo profondamente condizionati da un'ideologia, che sta alla base un pò della nostra società: la comodità, senza fatica e senza investimento.
È necessario comprendere prima di tutto che per ottenere ciò che si desidera, gli investimenti principali e probabilmente maggiore, dovrebbero essere diretti verso le nostre capacità, le nostre energie, salute, conoscenze e competenze, affinché ci possano poi permettere di raggiungere quel qualcosa o qualcuno tanto desiderato (a patto che ci interessi ancora a quel punto). Tutto questo, richiederà una certa scomodità, perché ci metterà probabilmente in una posizione diversa da quella attuale, ed è qui che nascono i primi accenni di fatica. Fatica che aumenterà dal momento in cui ci sarà da praticare o lavorare (in caso fosse necessario guadagnare di più), per ottenere quello che ci siamo prefissati.
Terzo aspetto, ma non meno importante, è che viviamo in un mondo che si basa sul confronto sociale, sull'ottenere di più per produrre di più, su meccanismi di velocità e priorità costante, sul consumo, sul tutto e subito. Tutti questi aspetti che hanno le loro rilevanti conseguenze.
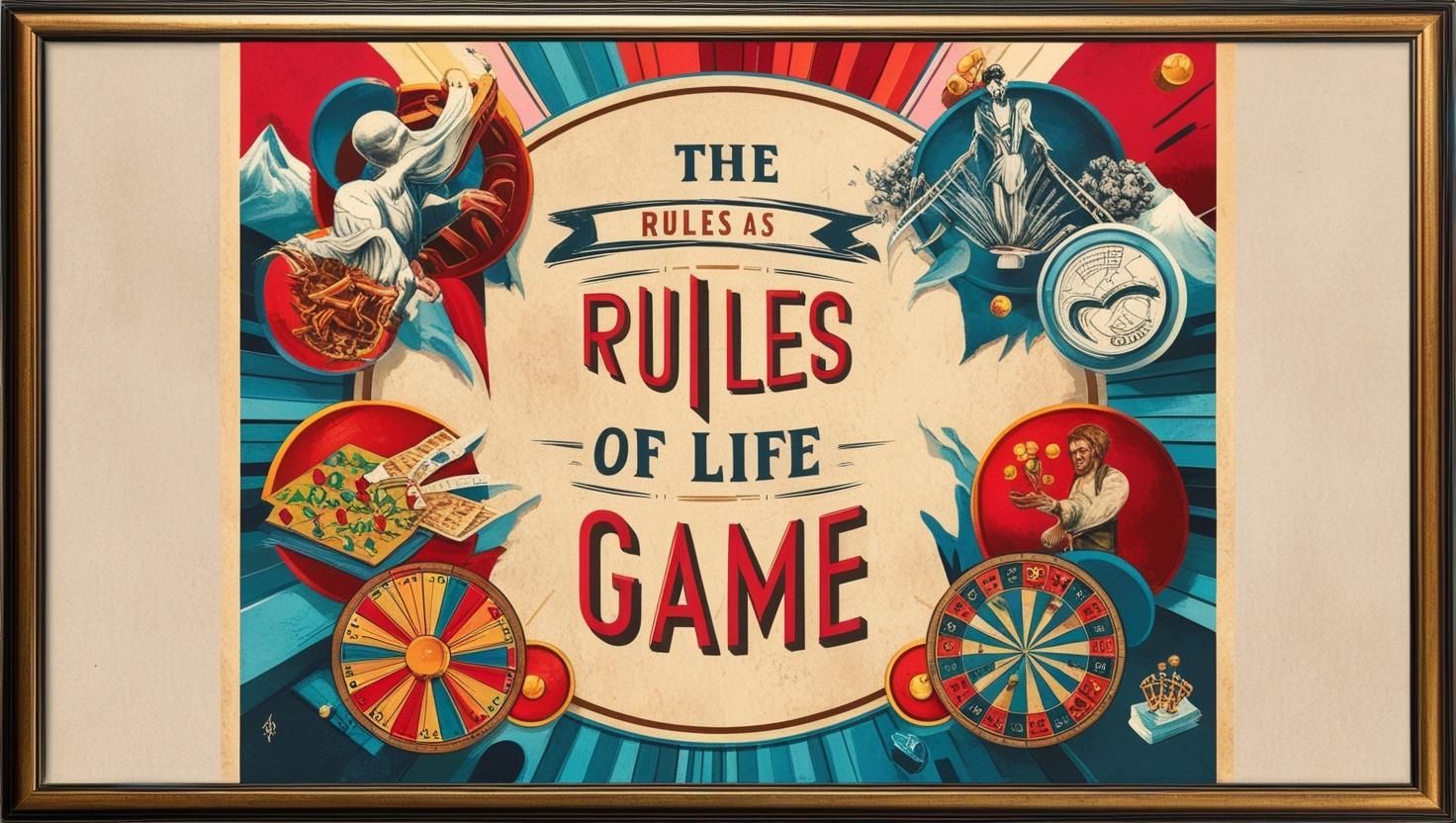
Difficoltà d'attesa, in tempi veloci
Velocità, priorità e urgenza per tutto, indistintamente. Ogni aspetto della nostra quotidianità è influenzato da questa velocità, perché a sua volta ogni cosa è diventata priorità, anche quando non lo è realmente.
"Coltiviamo" tempi veloci, tralasciando invece la qualità. La qualità non solo di ciò che produciamo e che siamo in grado di generare, ma anche del nostro tempo, delle relazioni, della comunicazione e così via su moltissimi aspetti che riguardano il nostro tessuto sociale.
Stiamo perdendo la nostra umanità e la nostra sensibilità, di fronte a una sempre più esigente e produttiva fast-life senza scrupoli. Non riconosciamo più l'essenziale, in quanto la velocità potenzia sempre più un atteggiamento superficiale, poco consapevole, dove porsi domande è una "perdita di tempo". Comprendere quali sono i principali aspetti che influenzano questa velocità, aumentando la difficoltà dell'attesa, potrebbe essere una soluzione per invertire una "rotta che rischia di portarci in porti poco sicuri".
- La velocità dei tempi è probabilmente uno dei fattori che dominano il nostro attuale panorama sociale. Un valore, un valore aggiunto a chi promette di fornirti tutto ciò che vuoi in maniera comoda e soprattutto sicura. La produzione, il consumo, i trasporti e ogni tipo di servizio devono rispondere a un parametro di velocità e non di qualità. Un ritmo frenetico e accelerato che altera la percezione del tempo, restringendolo in tempi sempre molto stretti. "Devi correre, se vuoi stare al passo".
- Un'alleata indiscussa della velocità è sicuramente l'immediatezza, che si promette di offrirti tutto "qui e ora". Elimina il senso dell'attesa e ci induce a processare gli eventi e la loro successione a una velocità che è fuori da ogni logica naturale. Snatura ogni aspetto della quotidianità. Scegli le relazioni con un "click" e con una "scrollata" vivi i momenti della tua vita. Musica in streaming, acquisti veloci e consegne supersoniche.
- Velocità e immediatezza non possono che far spazio a una cultura del "tutto e subito". Ogni nostra azione, ogni momento, è diventato una priorità. Non siamo più disposti ad attendere o a lavorare per ottenere ciò che desideriamo. Evitiamo il sacrificio (inteso come un corretto sforzo per ottenere determinati risultati) e abbracciamo una comodità scomodante.
- I social media hanno un grosso impatto sulla nostra società attuale e una significativa influenza su molti aspetti, tra questi troviamo proprio l'incapacità di saper attendere. Sono un amplificatore della cultura dell'immediatezza: per mezzo delle notifiche, dei continui aggiornamenti in tempo reale e della possibilità di comunicare in maniera istantanea, creano un ciclo di gratificazione immediata che lavora inconsciamente sulla nostra capacità di saper attendere. Siamo completamente alterati e, allo stesso tempo, ingannati da queste piattaforme, che inducono a non tollerare più le attese. Il confronto con le vite apparenti altrui "decompone" qualsiasi speranza riposta in una "sana attesa".
- Alla base dei social media c'è sicuramente lo zampino della tecnologia. Essa ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, trasformandolo completamente. Tanto più quest'ultima progredisce, tanto più diventano veloci i nostri strumenti e, al contempo, anche i nostri ritmi. Ci è stato promesso che questi strumenti avrebbero migliorato la nostra esistenza, ma in realtà, per molti aspetti, non fanno altro che peggiorarla. Internet, motori di ricerca, IA e quant'altro sono servizi che stanno demolendo i fisiologici tempi che differenziano l'essere umano dalle macchine.
- Produzione e consumo. Dobbiamo produrre, ma per produrre dobbiamo consumare. Per consumare dobbiamo acquistare prodotti scadenti, che hanno una vita breve, perché solo in questo modo il ciclo può essere alimentato. Mode e tendenze che sfrecciano a velocità altissime, figlie di questo meccanismo, dove nel mezzo ci siamo "noi" che ci caschiamo in pieno."
Qui di seguito alcuni studi allarmanti sul fenomeno:
- Uno studio del 2019 pubblicato sul Journal of Social and Clinical Psychology ha rilevato che limitare l'uso dei social media a 30 minuti al giorno ha portato a una significativa riduzione della solitudine e della depressione in un periodo di tre settimane. Questo suggerisce una correlazione tra l'uso eccessivo dei social media e la difficoltà a gestire l'attesa e il tempo "non produttivo"
- Un rapporto di Microsoft del 2015 ha rivelato che l'attenzione media dell'essere umano è scesa da 12 secondi nel 2000 a 8 secondi nel 2015, un calo del 33% in appena 15 anni. Questo è stato ampiamente attribuito all'aumento dell'uso di dispositivi digitali e all'esposizione costante a stimoli rapidi
- Secondo uno studio del 2021 pubblicato su Frontiers in Psychiatry, circa il 39% degli utenti di smartphone a livello globale mostra sintomi di dipendenza dal dispositivo. Questo si traduce in una maggiore difficoltà a tollerare momenti di inattività o attesa senza controllare il telefono.
- Un'indagine condotta da The Social Habit nel 2020 ha rivelato che il 42% dei consumatori si aspetta una risposta sui social media entro 60 minuti, mentre il 32% si aspetta una risposta entro 30 minuti. Questo evidenzia le aspettative di immediatezza create dai social media.
- Uno studio del 2019 pubblicato sul Journal of Clinical Sleep Medicine ha mostrato che l'89% degli adulti e il 75% dei bambini hanno almeno un dispositivo elettronico nella loro camera da letto. L'uso di questi dispositivi prima di dormire è associato a una riduzione della qualità del sonno, influenzando negativamente la capacità di rilassarsi e "staccare".
- Contrariamente alla percezione comune, uno studio dell'Università di Stanford del 2009 ha dimostrato che i pesanti utilizzatori di media digitali sono più facilmente distratti da stimoli irrilevanti e meno capaci di passare da un compito all'altro rispetto a coloro che usano meno i media digitali.
- Secondo il Digital 2021 Global Overview Report, l'utente medio trascorre 2 ore e 25 minuti al giorno sui social media. Questo tempo sottratto ad altre attività può contribuire alla sensazione di "mancanza di tempo" e all'impazienza.
- Uno studio del 2013 pubblicato su Computers in Human Behavior ha rilevato che il 56% degli utenti di social media sperimenta FOMO, la paura di perdersi qualcosa. Questo può portare a un controllo compulsivo dei dispositivi e a una diminuzione della capacità di essere presenti nel momento.
- Secondo un sondaggio di Deloitte del 2020, il 54% dei consumatori considera la consegna in 2 giorni come "veloce", mentre nel 2015 era considerata tale solo dal 35%. Questo dimostra come le aspettative di rapidità stiano aumentando nel tempo.
È inutile, a questo punto, di fronte all'evidenza, negare che ormai siamo sempre più incapaci di saperci godere il momento e che, anche quando l'attesa si presenta, non la sopportiamo, ma la viviamo come una vera e propria afflizione. Gli aspetti che influenzano l'attesa sono sia esterni, come abbiamo ampiamente visto, sia interni (il nostro modo di percepire le cose e le aspettative).
C'è solo una scelta sana da fare: comprendere consapevolmente che l'attesa non è altro che un nome che abbiamo dato a un momento che non abbiamo compreso fino in fondo: il vivere, il processo.