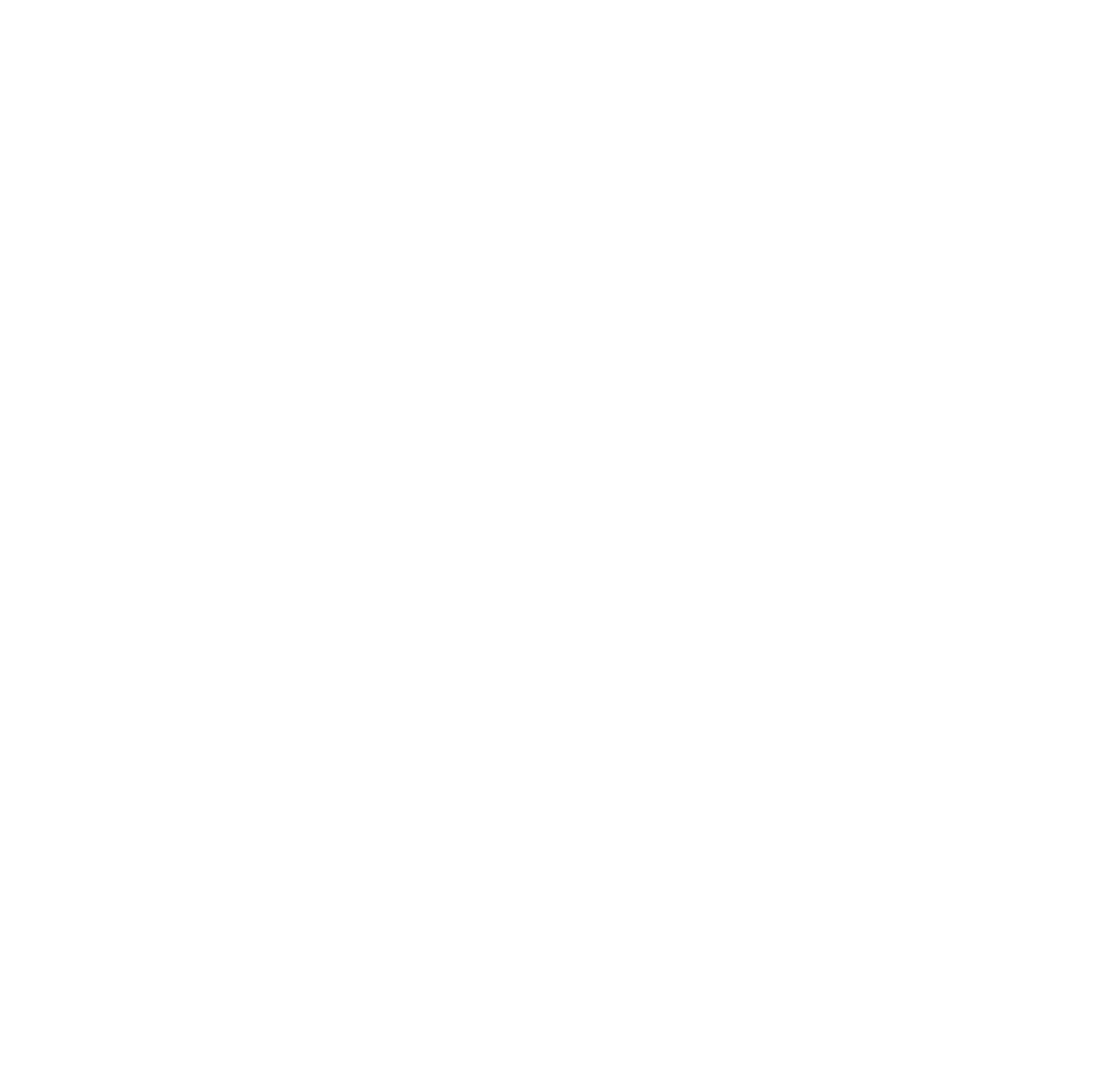Vivere con "il pilota automatico"
Abitudini
Siamo sognatori intrappolati dalle nostre abitudini, in routine che si ripetono all'infinito. Mascheriamo paure e insicurezze, mentre continuiamo a fare "sempre allo stesso modo". Abituati a condurre una doppia fatica, una contraddizione che ci divide in due: restare o cambiare?
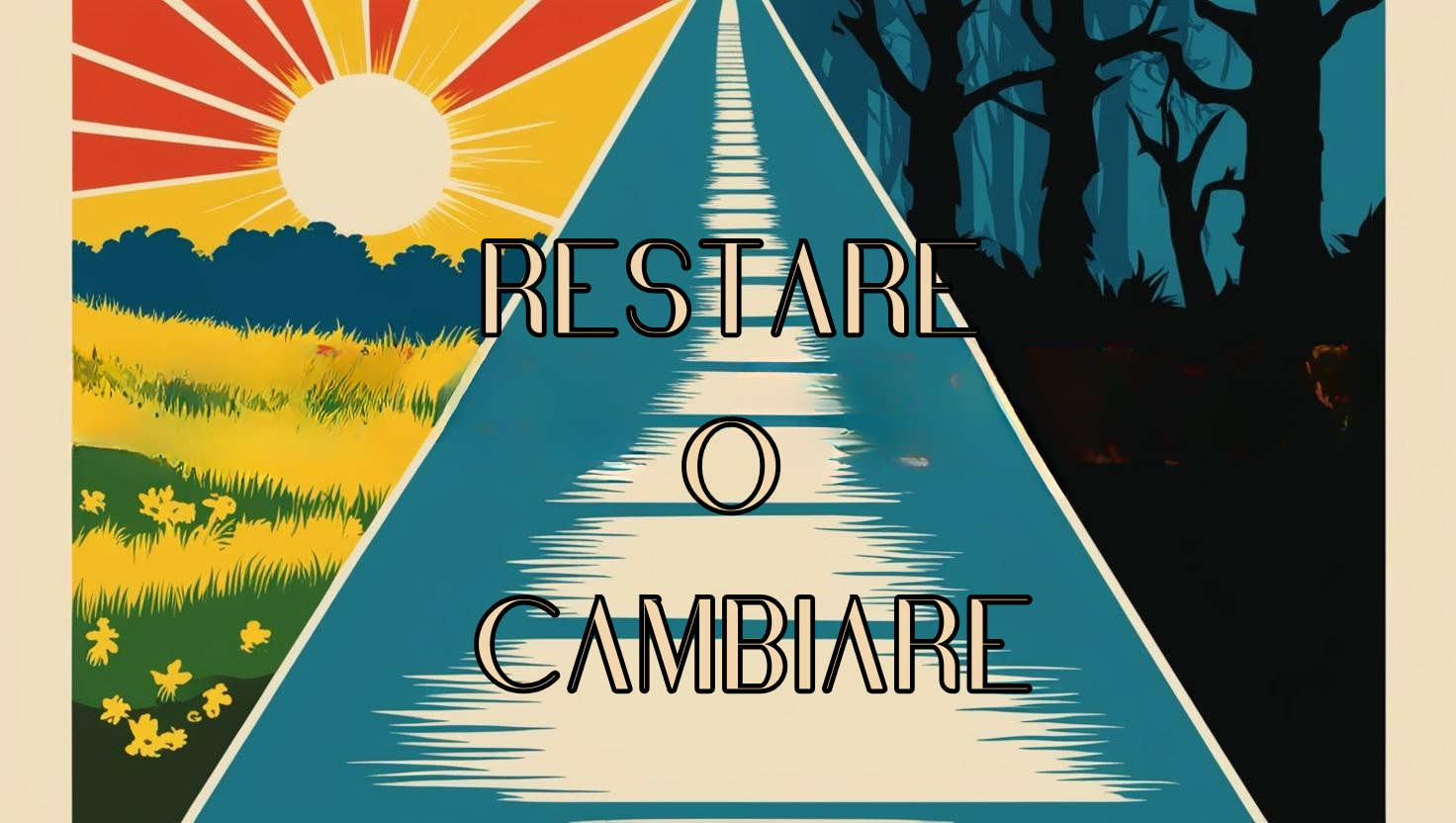
Abitudinari
Diversi sono gli elementi che intervengono a favore delle abitudini e della loro "sedimentazione" nel tempo. Di fatto, spesso nemmeno ce ne accorgiamo, ma siamo condizionati da questa modalità schematica, ripetitiva e consolidata in cui trascorriamo le nostre giornate, come in un carillon senza fine.
Un vero e proprio "pilota automatico" che ricerchiamo sempre più, perché nella routine troviamo, in un primo momento, sicurezza, stabilità, equilibrio e così via dicendo. "Lo facciamo a occhi chiusi", è facile, perché la conosciamo forse da anni, senza mai cambiare. Una serie di azioni e schemi comportamentali "installati" come un programma dentro di noi, che ci permettono di agire all'interno di quel solido "perimetro".
Un perimetro sicuramente sicuro, perché non permette in alcun modo di far "entrare" nulla dall'esterno. Il punto è che esso non permette solo di non far entrare, ma anche di uscire al di fuori di esso.
Gli elementi che portano a stazionare all'interno delle abitudini sono molteplici e con molteplici conseguenze. Sicuramente, tra gli aspetti più comuni, c'è proprio la paura: la paura del cambiamento.
Il suo termine tecnico è metatesiofobia, ed è una reazione emotiva, solitamente intensa e diffusa, che si manifesta proprio in seguito alla possibilità di un cambiamento oppure di fronte a un cambiamento stesso. Siamo "progettati" biologicamente per essere avversi e restii quando si presenta un cambiamento, giustificando così la paura e la staticità che contraddistingue la mente. Il cambiamento è, di fatto, qualcosa di ignoto che la mente non conosce e rifugge in tutti i modi, in quanto lo percepisce come una potenziale minaccia. È programmata per "sostare" in dinamiche familiari e che può controllare, dandole l'impressione di stabilità e sicurezza. Minor dispendio energetico, in quanto le abitudini, essendo collaudate nel tempo, permettono di svolgere azioni automatiche "senza pensarci", facendo sì che ogni cosa sia automatizzata in maniera efficace ed efficiente. Temiamo, inoltre, di non riuscire più a manifestare quel controllo che ci contraddistingue, in quanto il controllo ci dà quella sensazione di sicurezza e appagamento. Non solo, anche i margini di errore o la possibilità di fallimento vengono ridotti ai minimi termini, in quanto ormai sappiamo tutto e conosciamo tutto all'interno della nostra consolidata routine.
Abbiamo un vero e proprio attaccamento familiare, in quanto siamo animali abitudinari per natura; nel mix non poteva mancare anche un'innata resistenza alle novità (neofobia), che genera resistenze alle novità in sé.
Tutto questo cocktail di elementi genera una comodità imbattibile, stabile e, ahimè, duratura.
Perché vivere ansia, stress, preoccupazione, dispendio energetico, spostamento degli equilibri, rischio di blocchi emotivi o di ripercussioni somatiche, quando si può stare tranquillamente beati all'interno delle nostre care abitudini?
Abbiamo la "comfort zone", uno spazio mentale, una condizione cognitiva che ci fa sentire sicuri di noi stessi e delle nostre azioni. Porta i nostri comportamenti a fare scelte familiari, prevedibili, dalle performance stabili e caratterizzate da bassi livelli di ansia e stress.
Insieme, paura del cambiamento e comfort zone formano una relazione forte, un'interconnessione bidirezionale in cui il cambiamento diventa il motore che ci spinge a sviluppare e rafforzare questi due elementi. Le due sfere, essendo interconnesse, si influenzano a vicenda:
- la paura del cambiamento alimenta la comfort zone, in quanto, di fronte all'ansia e allo stress che si genera in vista di un cambiamento, la comfort zone rappresenta invece quella zona sicura, un rifugio dove ci sentiamo protetti.
- la comfort zone rafforza la paura del cambiamento, in quanto l'atteggiamento, così come la domanda, diventano: perché rischiare? Perché lasciare il sicuro per l'incerto? Abituati dalla comfort zone al certo e al prevedibile.
Insomma, preferiamo sicuramente la comodità della sicurezza, delle abitudini e della routine, ma quale tipo di sicurezza stiamo scegliendo? Quali sono le ripercussioni?

"Comodoni"
"Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, e non sa quel che trova."
Quante volte abbiamo sentito questa frase? Direi una predica, un invito, ancora una volta, a rimanere esattamente dove si è, presumibilmente al sicuro da ogni pericolo proveniente da ciò che non conosciamo. Ma chi stabilisce che al di là di ciò che conosciamo ci sia un pericolo? Anche lo stesso detto potrebbe essere interpretato non come un monito a non abbandonare la vecchia via, ma solo come un avvertimento: nel lasciare il vecchio per il nuovo, l'ignoto ci attenderà. E allora perché, partendo proprio da questo detto popolare, la nostra interpretazione è sempre stata la medesima? “Rimani dove sei, al di là del tuo perimetro di 'sicurezze' si nasconde il male”.
Le ragioni sono molteplici e si intrecciano tra caratteristiche biologiche che ci appartengono e fattori di tipo sociale.
Un progresso, statico
Sedimentare nelle abitudini e rimanere statici e fermi in esse non è sempre solo un atteggiamento o una scelta; vi si nascondono diverse ragioni, anche biologiche, che ci portano a essere predisposti a tutto questo. È vero anche che, oltre a ciò, intervengono importanti fattori sociali, psicologici ed emotivi che ci inducono a consolidare questo meccanismo. Un meccanismo che non è innocuo come pensiamo, ma che comporta ripercussioni che non valutiamo attentamente.
Ragioni biologiche
Tutto parte dalla “programmazione” del nostro cervello, un organo strutturato per ottimizzare e risparmiare, un organo conservatore che tende al risparmio energetico. Insomma, un “processore” che mira alla massima efficienza. Di conseguenza, istituire delle abitudini è un’azione fisiologica che serve proprio a ottimizzare le energie, dal momento che si presentano azioni quotidiane ripetitive. Infatti, quando un’azione viene compiuta più volte, i circuiti neurali coinvolti diventano via via più efficienti, richiedendo meno energie o attenzioni. In principio, tutto questo è fisiologicamente vantaggioso, poiché permette di liberare nuove energie disponibili per altre aree cognitive, che consentiranno di affrontare nuove sfide e nuovi stimoli.
I gangli della base sono una regione profonda del cervello, cruciale nella formazione delle abitudini. Essi collegano segnali ambientali (“cue”) a routine comportamentali che, a loro volta, conducono a ricompense. Una volta che si consolida il processo cue-routine-reward, l’abitudine si innesca quasi automaticamente, come un meccanismo predefinito. Ed è qui che entra in gioco la dopamina, in questo caso un neurotrasmettitore chiave nel processo di costruzione delle abitudini. Abbiamo detto che i comportamenti abitudinari portano a ricompense, date proprio dalla produzione di questo neurotrasmettitore. Quando impariamo una nuova abitudine, rilasciamo dopamina in dosi importanti, che, facendoci sentire un senso di ricompensa, benessere e appagamento, ci pone nelle condizioni di ricercare la medesima azione, per rivivere le medesime sensazioni. Tuttavia, con il tempo, la risposta dopaminergica si sposta: anziché essere rilasciata dopo l’azione abitudinaria, viene rilasciata prima, in seguito allo stimolo ambientale (“cue”) che precede l’abitudine. Ecco come si spiega uno dei motivi della dipendenza (psicologica) dalla sigaretta. A un certo punto, fumando una sigaretta, la dopamina viene rilasciata ancor prima di fumarla; quindi l’abitudine, il gesto stesso, ci induce a produrre dopamina in partenza. Di conseguenza, da un punto di vista psicologico, mettere una matita in bocca potrebbe fornire lo stesso rilascio di dopamina. Questo meccanismo porta così a fortificare in maniera significativa le abitudini, facendo sì che la persona faccia sempre più fatica a sperimentare altri stimoli. Abbiamo una vera e propria predisposizione biologico-evolutiva per la routine e per la prevedibilità, poiché in principio offrono stabilità e sicurezza in ambienti potenzialmente pericolosi. Infatti, conoscere percorsi sicuri, fonti di acqua e cibo e ambienti favorevoli allo sviluppo aumentava la possibilità di sopravvivenza. Questo tipo di predisposizione conservatrice può essere più forte in alcune persone, probabilmente a causa della sensibilità allo stress derivante dal cambiamento.
Ragioni sociali
Le ragioni sociali hanno un impatto significativo su di noi. L’ambiente definisce in maniera significativa l’animale umano, e lo stesso accade a noi in una società con molte norme e aspettative sociali. Infatti, sono numerosi i messaggi, impliciti o espliciti, che riceviamo ogni giorno nella nostra società. Stabilità, conformità e prevedibilità sono alla base degli incoraggiamenti sociali che riceviamo quotidianamente. Siamo incoraggiati a “sistemarci” nella vita, con un lavoro stabile, una famiglia, una casa, la macchina, le vacanze, il parrucchiere di fiducia, la spesa del sabato mattina e così via. Li chiamano percorsi di vita, “tradizioni” culturali e sociali, retaggio di un passato obsoleto e palesemente poco armonico e costruttivo. Questi indirizzi possono derivare da pressioni sociali implicite o esplicite, da ambienti come la famiglia, gli amici, la scuola, il posto di lavoro, i media, i social e così via. Questo perché ci viene insegnato che una deviazione da questi percorsi è chiaramente sbagliata, non conforme a ciò che è socialmente accettato come giusto e costruttivo. Il che non significa che sia giusto e costruttivo dal punto di vista personale. Temiamo così tanto la pressione sociale perché temiamo anche il giudizio in seguito a un possibile fallimento. Quindi la paura di fallire e di essere giudicati ci impedisce di fare scelte più affini a noi, rischiando così di accontentare gli altri piuttosto che rendere soddisfatti e felici noi stessi. Ma il limite non è solo nostro: in una società dove non “segui lo schema” vieni facilmente emarginato o escluso, in nome di una presunta normalità. In un modello sociale strutturato e costruito per aderire all’omologazione, è facile sentirsi “tagliati fuori”. Come già analizzato nel precedente articolo “Senso di comunità & Bene per sé stessi” (https://www.orientatibenessereesalute.com/senso-di-comunita-bene-per-se-stessi), l’uomo è un animale sociale che tende naturalmente a trovare approvazione e riconoscimento attraverso le relazioni affettive, all’interno della comunità in cui vive. Quindi il peso sociale non dipende solo da una mancata o scarsa gestione delle proprie insicurezze, ma anche da fattori prettamente biologici e antropologici. Le strutture sociali vigenti, come un lavoro stabile, una casa di proprietà, relazioni a lungo termine, i matrimoni e così via, danno appunto quel senso di sicurezza e, allo stesso tempo, di identità, proprio perché conformi a quegli aspetti accettati come “giusti” dalla società. Infatti, chi tende a invertire la tendenza e a scegliere di cambiare questi aspetti viene definito anarchico, sbagliato, in poche parole, non ben accetto. A sostegno di queste strutture sociali ci sono tradizioni e narrazioni culturali che delimitano in maniera chiara “come si è sempre fatto”. Questo instilla, fin dalla nascita, false credenze sul come dovrebbe essere condotta la vita, anche se questa non ci appartiene realmente.
Fattori psicologici
Si guadagnano il primato in classifica, come già anticipato, la paura del fallimento e dell’ignoto. La possibilità di non gestire il mancato raggiungimento di un obiettivo, e quindi un possibile fallimento, così come il timore di ciò che non si conosce e l’incertezza del futuro, paralizzano completamente le possibili azioni e, di conseguenza, le iniziative verso nuovi orizzonti e cambiamenti. A seguire, una bassa autostima e la scarsa fiducia in sé stessi non permettono di sostenere la possibilità di un cambiamento. Infatti, non credere in sé stessi e nelle proprie capacità fa sì che non si creda nemmeno nella possibilità di poter cambiare. Tra gli elementi che influiscono negativamente sulla possibilità di cambiare, troviamo due bias cognitivi. Il primo è il bias di conferma, che porta a trovare solo conferme su esperienze che non sono andate bene, rafforzando così l’idea che cambiare non sia necessario. Il secondo è il bias dello status quo, ovvero preferire la situazione attuale, rifiutando il cambiamento, anche se potenzialmente vantaggioso.
Fattori ambientali
Un tema che ricorre spesso sui media è che i giovani non si muovono, sono statici, spenti e demotivati già in partenza. Spesso interventi o dibattiti fuori luogo e inappropriati non considerano una delle ragioni di questa incapacità giovanile. Ad esempio, le risorse sono cambiate in termini di disponibilità. Non si parla di strumenti, ma di risorse sia ambientali che sociali. Se ci riferiamo a quelle ambientali, possiamo dire che stiamo vivendo una profonda crisi energetica e delle diverse materie prime, che prima si credevano inesauribili. Se ci riferiamo a quelle sociali, un ragazzo vissuto nel 1990, all’età di venticinque anni, aveva a disposizione la possibilità di costruirsi una carriera, basata magari su un’attività gestita in proprio oppure attraverso una filiera di aziende che offrivano margini di crescita professionali non da poco. Salari diversi, moneta diversa, assenza di crisi, una politica forse più efficace e meno scellerata di quella attuale: insomma, una catena di fattori che favorivano crescita e sviluppo. Oggi la paura di cambiare, di uscire dalle proprie abitudini e reinventarsi deriva anche da questo fattore, che incide profondamente nelle nuove generazioni, mentre quella vecchia, continua ancora a giudicare.
Le conseguenze
"Immagina di avere una pentola piena d'acqua fredda. Prendi una rana e mettila dentro. L'acqua è piacevole, alla temperatura ideale per una rana. Ora accendi il fornello sotto la pentola, molto lentamente, a fuoco bassissimo. All'inizio, la rana si gode l'acqua fresca. Nuota tranquilla, si rilassa. Mentre l'acqua inizia a scaldarsi, in modo molto graduale, la rana si adatta lentamente al cambiamento. La temperatura sale impercettibilmente, di grado in grado. La rana continua a nuotare, pensando che tutto vada bene, senza percepire un pericolo immediato. Il suo corpo si adatta al calore crescente, senza che scatti alcun allarme. Ma l'acqua continua a scaldarsi, sempre di più. A un certo punto, la rana inizia a sentirsi a disagio: l'acqua è troppo calda e comincia a stancarsi di nuotare in quell'acqua che non è più piacevole. Tuttavia, a questo punto, la rana è diventata troppo debole, assopita dal graduale aumento di temperatura. Non ha più l'energia, la forza di volontà o la lucidità per saltare fuori dalla pentola. Ha sprecato le sue energie adattandosi a un cambiamento impercettibile, invece di reagire a un pericolo crescente. Alla fine, l'acqua diventa bollente. La rana non riesce più a sopportare il calore, ma è troppo tardi. Sfinita e incapace di reagire, muore bollita"
Questa storia, seppur semplice, esprime in maniera diretta e chiara il concetto delle possibili conseguenze di una mancata capacità o volontà di adattamento: un processo graduale che porta inevitabilmente al malessere, o alla morte (e ci sono diversi modi di morire). Di fatto, viviamo in una società che ha raggiunto un certo progresso tecnologico e scientifico, ma che, sotto l'aspetto sociale, economico e morale, ha subito una vera e propria involuzione. Una società decadente, che si rifà a vecchi modi di fare e di pensare, stagnante in abitudini obsolete e inadeguate. Non si tratta di progresso o di cambiamento in nome di una tendenza, ma della necessità di cambiare per non affondare, per non raggiungere quel limite a cui ci stiamo pericolosamente avvicinando. Passivi e mai attivi, con le zavorre ai piedi, affrontiamo le nostre giornate, illudendoci di essere salvi all'interno delle nostre routine perfette. Una mancata crescita personale, un'insoddisfazione perenne derivante proprio dalla mancata opportunità di conoscere sé stessi; e allo stesso tempo, nessuna abilità, nessuna competenza, nessuna evoluzione relazionale, sociale, economica e così via. Tutti fattori che contribuiscono a creare una società che ormai ha mancato il vero obiettivo alla base: evolvere per mezzo di persone intellettualmente, emotivamente e socialmente evolute.

Un mo(n)do nuovo
Immaginarsi in modo diverso: una rivoluzione concettuale, e non solo. Agire, muoversi e stare al passo con l'unica vera verità: tutto è soggetto a cambiamento. Non siamo rocce inamovibili, ma piume destinate a farci trasportare dal vento. La necessità è racchiusa in due passaggi significativi: comprendere il concetto di cambiamento e agire con azioni costruttive ed efficaci, al passo con esso.
"Panta rei", non c'è abitudine che tenga
È una locuzione greca che si traduce letteralmente con "tutto scorre". La filosofia di Eraclito si incentra esattamente su questo concetto, analizzando il continuo mutamento, l'eterna evoluzione, anche in cose che potrebbero sembrare sempre uguali. Divenire e mutamento: due elementi distintivi della realtà. L'invito del celebre filosofo è molto chiaro: vuole risvegliare ogni individuo dall'apparenza dei sensi, che ci fanno percepire ciò che viviamo in maniera statica e immutabile. Un'illusione, una nostra errata percezione delle cose. Cose che ci appaiono solide, definite, permanenti e immutabili, in realtà sono soggette a un cambiamento perpetuo, in cui nulla rimane uguale al momento precedente. Il cambiamento è visto come un fiume che scorre ininterrottamente. Ed è proprio da qui che Eraclito estrapola la sua metafora più celebre, per illustrare il concetto del Panta Rei: "Non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza mortale nel medesimo stato".
Sostanzialmente, il filosofo afferma che, se getto ad esempio un sasso nel fiume, esso non verrà bagnato mai dalla stessa acqua e lo stesso sasso non sarà mai lo stesso. Qui, di fatto, viene messo a confronto un oggetto apparentemente immutabile e la forza perpetua del fiume che cambia continuamente. Il sasso fermo nel fiume, pur non essendo bagnato dalle stesse acque, subirà cambiamenti continui. Da questa filosofia dovremmo apprendere e interiorizzare molto. Potremmo essere rappresentati anche noi come pietre, inamovibili e ferme, in un mondo che cambia, e che lo fa anche velocemente. La situazione vede due parti nettamente divise: da una parte il cambiamento e una rivoluzione continua in ambito tecnologico, informatico, tecnico e della conoscenza; dall'altra, dal punto di vista culturale, sociale, climatico e del benessere, stiamo vivendo un'involuzione che ci porta a non avere le giuste capacità per gestire tutto questo progresso.
Tutto ciò lo possiamo vedere chiaramente oggi, attraverso una cultura tramandata dalle generazioni precedenti che "ci ha insegnato" a investire in cose che ormai hanno un valore diverso, un significato diverso e che a volte non esistono affatto. Parlare ancora di lavoro sicuro, del famoso posto fisso, cioè di una posizione lavorativa e redditizia che permette di garantire stabilità finanziaria e sociale come conseguenza, o di investimenti nel "mattone", in case e mutui per ottenere immobili e proprietà, non è nient'altro che indice di sicurezza, prosperità e garanzie future. Ma oggi non è più così. Anche a livello relazionale le cose sono cambiate. Non si tratta di genere, etnie o religioni, ma di questioni che vanno propriamente alla base. Un tempo, la scelta del proprio compagno o compagna di vita avveniva sulla base di una scarsa conoscenza di sé e delle relazioni stesse. Questo, di fatto, ha portato le vecchie generazioni, e anche le attuali, ad avere una certa incapacità gestionale della relazione stessa. Se prima si restava insieme per obbligo, senza comprendere la libertà di essere sé stessi all'interno della relazione, oggi si assiste invece a un fenomeno "consumistico" delle relazioni: se non va bene cambio, se non funziona lascio e, a ogni prima avvisaglia di difficoltà, si fanno “resi”, poiché il nuovo acquisto non soddisfa più le esigenze. Perché accade questo? Perché non siamo abituati a cambiare, non comprendiamo che il cambiamento avviene all'interno delle relazioni stesse, dove muta chi è all'interno della relazione, mutano i significati e muta il modo di vivere la relazione stessa.
Ma la verità è sempre una sola: non esiste una condizione che non sia soggetta a cambiamento o mutamento. Ma cosa vuol dire cambiare? Vuol dire cambiare ogni volta posto di lavoro, partner, casa, macchina, vestiti e così via? O piuttosto chiedersi se dovremmo cambiare noi stessi, magari il nostro modo di vedere le cose, il modo in cui le pensiamo o il modo in cui stiamo vivendo la nostra vita? Guardare dentro e non sempre fuori.
Il cambiamento arriva per mostrare semplicemente una cosa: che hai bisogno di far evolvere te stesso o qualche parte di te. Non è una punizione o uno sbaglio, come spesso ci capita di pensare, anzi, è una vera e propria benedizione, poiché ci porta verso uno stato migliore, in cui c'è una condizione di equilibrio e consapevolezza maggiore. Lo sbaglio è invece impegnare molte delle nostre energie nel combatterlo, nel non accettare che le cose possano cambiare. Solitamente, quando arriva un cambiamento, si ha la tendenza a trovare solo una parziale forma di adattamento, in cui si "limano" solo parti superficiali, quando in realtà il cambiamento è profondo e a volte sconvolgente. Non esiste una condizione che non sia soggetta a cambiamento e, una volta che arriva, non si torna più indietro. Prima lo si accetta, prima arriveranno i benefici del cambiamento stesso. Mentre, cosa accade quando non lo si fa?
Un impossibile rifiuto
Rifiutare il cambiamento è impossibile, ma impegnando molte energie è possibile rimandarlo. Questo rimando porta, chiaramente, a delle conseguenze:
- Stagnazione, ignoranza e mancanza di crescita personale. Questi tre elementi, insieme, rappresentano la morte di ogni possibile opportunità futura, e quindi per sé stessi. La vita che si basa sull'apprendimento continuo richiede, di fatto, una crescita personale costante.
- Ridotta adattabilità e assenza di evoluzione. Chi rifiuta il cambiamento, rifiuta una sfida che la vita pone per poter migliorare, evolvendo in altro. Negare tutto questo porta a diventare sempre meno abili rispetto alle sfide e alle difficoltà che il cambiamento comporta.
- Noia e insoddisfazione. Spesso il cambiamento è uno stimolo, e allo stesso tempo è fonte di nuovi stimoli. Rimandare o rifiutare il cambiamento ci pone, di conseguenza, in una condizione di assenza di stimoli, che porta a noia e profonda insoddisfazione.
- Pigrizia. La pigrizia, oltre a essere una componente del possibile rifiuto del cambiamento, è anche la matrice delle nevrosi. Con il termine nevrosi si indica l'insieme dei disturbi psicopatologici (dispnea, ansia, depressione, ecc.).
- Rimpianti. Rifiutare il cambiamento vuol dire precludersi ogni tipo di possibilità a nuove opportunità, personali o professionali che siano.
- Isolamento sociale. Chi non cambia, fatica a stare al passo con i diversi cambiamenti che avvengono anche all'interno della società. Di conseguenza, anche la partecipazione alla vita sociale diminuisce, in quanto ci si ritrova "fuori dai giochi".
- Difficoltà nelle relazioni. Chiaramente, il conseguente isolamento sociale dato dal rifiuto del cambiamento porta a inevitabili difficoltà a livello relazionale. Oltre a questo, il rifiuto del cambiamento spesso genera incomprensioni e conflitti che, a loro volta, conducono a “asimmetrie relazionali”.
- A livello psicologico. Il continuo rifiuto del cambiamento porta anche a disagi a livello psicologico. Ansia e stress sono i primi due fattori che entrano in gioco, poiché le resistenze al cambiamento portano a uno stato di tensione continua. Il tutto è spesso contornato da una mancanza di autostima, in quanto, in assenza di cambiamento, si interiorizza un'immagine di sé rigida e limitata, incapace di adattamento. A livello cognitivo si diventa sempre più rigidi, inibendo così la sfera creativa, che si atrofizza. Tutto ciò può portare a disturbi o vere e proprie patologie legate alla salute mentale.

La scelta
Nonostante il cambiamento sia una condizione inevitabile e irreversibile, è allo stesso tempo anche una scelta. Chi lo affronta consapevolmente, sceglie di gestire il proprio "veliero", non la vita. Immagina di essere il capitano di una nave (la tua vita) in mezzo al mare (gli eventi). Chiaramente, non hai potere sulla forza del mare, ma puoi governare la tua nave, scegliendo rotte (le scelte) che ti porteranno a nuove scoperte (il cambiamento) e isole paradisiache (l'equilibrio consapevole).